
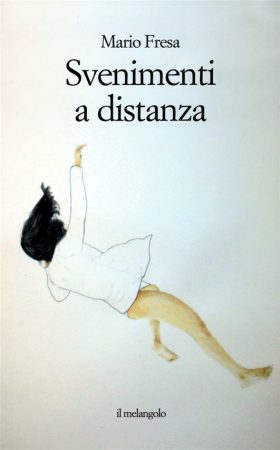 I versi di Mario Fresa colpiscono immediatamente per la loro delicatezza e per il loro vigore. Questi due termini potrebbero porsi sbrigativamente in opposizione, considerando l’uno l’opposto dell’altro. In questi testi invece si realizza un’interessante forma compositiva che mi ricorda tanto la grazia del San Michele Arcangelo di Marco Pino, rappresentato dal pittore nell’atto di uccidere il drago. La scena descritta, nonostante conservi salva la forza e l’energia del gesto, appare tuttavia assolutamente aggraziata, quasi come se San Michele danzasse sul nemico. È proprio questa grazia apparentemente contrastante con la scena a trasmettere invece un messaggio di sicurezza e soprattutto di saggezza, che colpisce qualunque osservatore attento. Lo stesso avviene con i versi di Fresa, minimi, aggraziati, delicati, eppure duri, saldi, come il piede di San Michele sulla testa del nemico. I personaggi che sfilano nei testi sono chiamati per nome e presentati con una semplicità quasi francescana. In questa prassi riconosco molto del suo autore, raffinato critico letterario e musicale, che nel suo lavoro è animato da una disciplina molto rigida che lo porta a lavorare sodo e lungamente sulle cose. Si tratta di una vera e propria “regola” che trova anche nell’esercizio poetico la sua realizzazione. Di particolare tenerezza mi è risultato Luigi, il personaggio che ogni tanto “solleva qualche risposta, magra balbuzie di vero drago”. Forse perché vissuta direttamente da bambina, l’immagine della balbuzie associata ad un drago mi è sembrata, oltre che molto efficace nella sua coraggiosa associazione ossimorica, anche e soprattutto infinitamente estendibile nella sua portata filosofica. Questo verso racchiude in modo intimo e definitivo la condizione dell’uomo, che Fresa pone in una esistenza sostanzialmente incapace di autodeterminarsi e persino di desiderare, restando lì, animata solo dalla sua illusione, proprio come gli schiavi della caverna platonica. Non importa dunque che lo spessore filosofico sia quello di un drago, e che l’energia vitalistica sia piena, tutto si risolve in un nulla di fatto. Anche la personalità è condannata a restare sulla soglia, punto di osservazione tanto promettente quanto illusorio. Per dirla platonicamente, l’uomo vive di ombre e al poeta non spetta che “registrare” questa arida realtà, dicendola con fermezza ma con un tatto proveniente dal rispetto e dalla condizione di compassione. Il limite della pelle è esso stesso blando, non tiene nulla di coeso al punto di chiedersi “su questa terra non è rimasto più nessuno?” Questo scenario disperante è più che post novecentesco, in quanto non si tratta di una soggettività frammentata e caduca, ma di qualcosa che non è mai esistito. Questo pensiero credo sia una sorte di piccola e abissale “ossessione” di Fresa che aleggia come un colossale contrappeso su tutta la sua produzione critica. Tuttavia, lungi dal demotivarlo o dal portarlo a geremiadi melense, gli procura statura morale, soprattutto dandogli un senso spiccato della proporzione. Mi ha avvinto particolarmente il passo in cui la giovinezza torna a “fare se stessa” e l’autore le dice “avremo tempo e odore”. Quanta grazia in questa immagine, sembra quasi scritto da una donna, questo riferimento ad un odore andato che diventa sinesteticamente la gioventù stessa. L’immagine è di proustiana memoria. L’odore riesce ad essere un ottimo traghettatore temporale, portandoci immediatamente in un altro tempo, in un altro luogo. Oltretutto il fatto stesso di nominarlo ne fa sentire uno, particolare, ognuno il proprio, quello della propria giovinezza. Ed è proprio in questa dimensione minuscola che i personaggi di Mario e noi tutti riusciamo ad esistere in quanto tali, in una dimensione che ci porta a scomparire, come in uno svenimento, a perderci per poi trovare a terra, una ad una tutte le nostre piccole cose, che ci ricordano chi siamo senza poterlo spiegare (Federica Giordano).
I versi di Mario Fresa colpiscono immediatamente per la loro delicatezza e per il loro vigore. Questi due termini potrebbero porsi sbrigativamente in opposizione, considerando l’uno l’opposto dell’altro. In questi testi invece si realizza un’interessante forma compositiva che mi ricorda tanto la grazia del San Michele Arcangelo di Marco Pino, rappresentato dal pittore nell’atto di uccidere il drago. La scena descritta, nonostante conservi salva la forza e l’energia del gesto, appare tuttavia assolutamente aggraziata, quasi come se San Michele danzasse sul nemico. È proprio questa grazia apparentemente contrastante con la scena a trasmettere invece un messaggio di sicurezza e soprattutto di saggezza, che colpisce qualunque osservatore attento. Lo stesso avviene con i versi di Fresa, minimi, aggraziati, delicati, eppure duri, saldi, come il piede di San Michele sulla testa del nemico. I personaggi che sfilano nei testi sono chiamati per nome e presentati con una semplicità quasi francescana. In questa prassi riconosco molto del suo autore, raffinato critico letterario e musicale, che nel suo lavoro è animato da una disciplina molto rigida che lo porta a lavorare sodo e lungamente sulle cose. Si tratta di una vera e propria “regola” che trova anche nell’esercizio poetico la sua realizzazione. Di particolare tenerezza mi è risultato Luigi, il personaggio che ogni tanto “solleva qualche risposta, magra balbuzie di vero drago”. Forse perché vissuta direttamente da bambina, l’immagine della balbuzie associata ad un drago mi è sembrata, oltre che molto efficace nella sua coraggiosa associazione ossimorica, anche e soprattutto infinitamente estendibile nella sua portata filosofica. Questo verso racchiude in modo intimo e definitivo la condizione dell’uomo, che Fresa pone in una esistenza sostanzialmente incapace di autodeterminarsi e persino di desiderare, restando lì, animata solo dalla sua illusione, proprio come gli schiavi della caverna platonica. Non importa dunque che lo spessore filosofico sia quello di un drago, e che l’energia vitalistica sia piena, tutto si risolve in un nulla di fatto. Anche la personalità è condannata a restare sulla soglia, punto di osservazione tanto promettente quanto illusorio. Per dirla platonicamente, l’uomo vive di ombre e al poeta non spetta che “registrare” questa arida realtà, dicendola con fermezza ma con un tatto proveniente dal rispetto e dalla condizione di compassione. Il limite della pelle è esso stesso blando, non tiene nulla di coeso al punto di chiedersi “su questa terra non è rimasto più nessuno?” Questo scenario disperante è più che post novecentesco, in quanto non si tratta di una soggettività frammentata e caduca, ma di qualcosa che non è mai esistito. Questo pensiero credo sia una sorte di piccola e abissale “ossessione” di Fresa che aleggia come un colossale contrappeso su tutta la sua produzione critica. Tuttavia, lungi dal demotivarlo o dal portarlo a geremiadi melense, gli procura statura morale, soprattutto dandogli un senso spiccato della proporzione. Mi ha avvinto particolarmente il passo in cui la giovinezza torna a “fare se stessa” e l’autore le dice “avremo tempo e odore”. Quanta grazia in questa immagine, sembra quasi scritto da una donna, questo riferimento ad un odore andato che diventa sinesteticamente la gioventù stessa. L’immagine è di proustiana memoria. L’odore riesce ad essere un ottimo traghettatore temporale, portandoci immediatamente in un altro tempo, in un altro luogo. Oltretutto il fatto stesso di nominarlo ne fa sentire uno, particolare, ognuno il proprio, quello della propria giovinezza. Ed è proprio in questa dimensione minuscola che i personaggi di Mario e noi tutti riusciamo ad esistere in quanto tali, in una dimensione che ci porta a scomparire, come in uno svenimento, a perderci per poi trovare a terra, una ad una tutte le nostre piccole cose, che ci ricordano chi siamo senza poterlo spiegare (Federica Giordano).
* * *
La ragione è una polvere buccia
ed è a un passo da me.
La uso come timpano gentile
e la do tutta ai doganieri: Sabato, Bruno, la Betti;
perfino i due Cirillo; anche a sua figlia Chiara.
Precisi animali; sempre mancanti,
lamentosi. D’istinto si camuffano,
allora, e fanno i dimostranti; il viso
si chiama Chiara camminante.
E tu sei troppo carica, le dico! Anzi, al confronto,
sembri un attacco feroce alla democrazia.
Tu mosca di classe, da fine degli studi;
amica reazionaria e
fretta mutazione. Così fumo davvero, in questi
giorni, cento pacchetti di meraviglia:
per non essere te, mosca o ragione,
con le mani affogate in un’ombra
leggera di memoria.
*
Si sdraia come una foto e chiama
addosso te, nel mezzo della malaria amore.
Allora Garinei, contro Luisa,
dice di essere, all’Ispettore, più un uomo vivo
che l’ultimo arrivato.
Ma un uomo vivo, protesto io, casca sempre
nelle parole altrui; e muore ogni minuto
ad ogni nuovo nome decifrato:
Garinei, Luisa, Pio.
E questa firma, caduta
in una crepa, ti fa davvero un occhio
quasi glaciale; è un gigante da lavoro, da biglietto
di auguri; e non so leggerlo più.
Ha un odore narice
che nessuno lo capisce, a parte me…
… e infine un’esplosione s’alza,
facendo ribollire, confusamente
insieme, respiro e verità…
*
Qui c’è un’altezza liquida, confusa nella camera zitta
e sincera come poche: nodo legato subito al sonno.
Luigi, al primo posto, dice di avere
qualche ramo di anarchia.
Non gli va molto di studiare. Solleva piano
qualche risposta: magra balbuzie
di vero drago. Ma la gente non vuole
questi regali da lingua assurda: vuole carne,
esperienza, solidità; contare prima e poi
capire. Così, tutti d’accordo,
riaprono il film: nel primo tempo, il diavolo
getta la borsa al fiume
e continua a estrarre rubli sonanti: Uno ne togli
e un altro, come vedi, è sempre lì.
Spedisce a fondo ogni preghiera
e ride tutta, lei, come una fabbrica di povera
salita; il male attaccato alla parete spegne
la luce, e non risponde più.
*
Tutti anneghiamo alle nostre spalle come
una lingua sottile da caviglia:
un po’ di magro territorio che non ci fa
sparire come vogliamo. Smisto i santi in pacchetti
da mille, e li divoro come vengono, così, sotto le dita,
visto che – a conti fatti – lo spirito sconcerta
e parla fino al limite preciso della pelle.
Allora buonanotte, mi dice lui – sottile
come un dito: su questa terra,
dunque, non è rimasto più nessuno?
*
Perché, sia chiaro, io non accetto qualsiasi cosa,
mostrata o no; la giornata dura per obbligo, ricade
in suoni narrazioni; da lì, torme lampade ginocchia
si levano, illudendo, come due occhi vivi: calcoli amici,
a contrappelo. E tu, fosca cosiddetta giovinezza,
cosa pensi di me, sotto quest’uragano?
Non so neppure se poi ti riavvicini a fare
la dolce somigliante; avremo tempo e odore,
anche per questo. Leggerezza, di qua, da ricucire,
che proviene da te, carte alla mano.
Deità, sorriso, nascondimento.
L’oggetto del desiderio
Il nonno l’ha trovata unita al nome del mittente, senza nessuna
spiegazione per la bocca andata quasi in pezzi, solo per lei;
e appena la sua amica se n’è andata, biascica il nonno sulla via,
si tira le ginocchia fino al petto e si fa tutto indietro,
come ha detto sua sorella Leonora (smascherata solo alla fine):
ma che succede? Si sveglierà con un feroce mal di testa e
ricadrà nel fumo dell’intera scolaresca; e intanto trema tutta,
così, mentre il motivo lo invade e prende le distanze solo due giorni
prima della scelta: finale da stanza-padre. Rimorso e questo
inverno. Il fatto è che non ha davvero altro, nella sua testa:
pensa alla sua faccia di animale appeso al gancio.
L’infanzia è un parlatorio interpretato da lui: piano, sedute
memorabili, con tutti i segni dello sfacelo ‒ da dormire proprio
a lungo, fino a creare quell’imprevisto, selvaggio sorriso:
facciamo che alla fine ci trovano di notte, e noi ce ne fuggiamo
come nel sonno, correndo a perdifiato,
con l’illusione di non muoverci mai più?
*
Anche tu sembri ammalato. Oh sì, l’ho visto.
Facevo la ronda battendo il fiammifero sopra le porte.
Se temi l’umidità, noi gli vorremo bene lo stesso.
C’è pane in abbondanza e vino aspro.
Ma lascia che ti dia qualcosa da metterti addosso.
E intanto, vorresti che ti avesse tenuta prigioniera…
come il primo motore in disaccordo col secondo,
o come due fratelli atterriti: e il mare-serpente
le sfiora il piede e tutti i suoi amici continuano
a descriverla da viva, per non dimenticarla così presto…
*
Alcuni gli vogliono bene quanto basta, felice purgatorio
senza vele – e lui così, turbante sulle gambe; occhio sparito
fin dal principio; si sposerà? –. Eppure adesso gli sale
tra le gote un vento leggerissimo che resta
senza pace. Poi lascia la nostra roba all’aria,
e nel silenzio messo presto in discussione (gridare
dalla finestra fino a volersi rovinare proprio il mento,
le gambe, la prossima stagione…).
Più centrale, più acuta. Se ne ricorderà.
Ecco la luce che fa più uguale, adesso,
il tuo veloce sguardo al mio.
I nomi precipitati giù dall’ascensore, o semiaperti,
dimenticati; confusi soprattutto per il caldo innaturale.
Un accidenti che vuole proprio me, anche se dice
di non sapere amare.
Se qualcuno, cioè, gli vuole bene,
non lo dirà proprio a nessuno.
Mai rendere pubblico un disastro.
*
Lui, separato dal ghiaccio e più tranquillo del solito,
la pesca tutta fuori dai vetri, e sotto la scorza dei dati
geografici la troverà, nel giro di una sera; voglio dire:
mi coglierà a pesare una strana felicità, da bianchissimo
destino dimenticato. Così diventa quadrato e ansioso:
scongiura di lasciarlo ai suoi affari, e ride come
uno schiavo allegro. Il giorno dopo lo trova casualmente,
Giuliana bambina, condannato
di fronte alle sue stesse pagine; e poi gli sembra irresistibile,
e ripete che ci vuole molta pietà: orrori quasi normali da queste parti,
si ripete di continuo: ma non certo per te.
Nessuno può augurare che muoiano? Possiamo essere casti?
Il primo prodigio, intanto, è nella peste.
Ce ne ricorderemo, ce ne ricorderemo…
E più avanti, la guida a mezz’aria ci ricorda:
amaro chi a sue spese si castiga.
(da Svenimenti a distanza, il melangolo, 2018)