
L’avevo sentito a telefono appena una settimana prima che se ne andasse, il 1° di aprile 2022, a Napoli (dove viveva sin da giovane), nel giorno del proverbiale “pesce d’aprile”, cioè in un giorno di scherzi. Negli ultimi tempi, per via della sua malattia, ci tenevamo in contatto solo tramite il telefono, due-tre volte al mese, raccontandoci le nostre vicende umane e letterarie, ma da un po’ di tempo le nostre chiacchierate ricadevano anche sul suo ormai minato stato di salute.
La sua voce stanca e debole non lasciava intendere niente di buono. Tra le poche cose che riuscì a dirmi fu un sentimento penoso: era molto dispiaciuto di sentirsi solo, di avvertire una solitudine intorno e la mancanza di una telefonata di qualche amico. «Vuoi che venga a farti compagnia?». La risposta fu un no che avrebbe voluto fosse un sì, messo a tacere evidentemente da una dignità commista ad una soggezione ‒ come spesso avviene in casi del genere ‒. Forse la mia è stata l’ultima o una delle ultime telefonate ricevute da un amico. Proprio alla vigilia della sua morte ne parlavo con Marisa Papa Ruggiero delle pessime condizioni di salute di Ugo, del nostro comune e indimenticabile amico.
Prima di continuare in questo doloroso ricordo, una breve puntualizzazione: ho scritto nel titolo epicedio, cioè antico canto funebre greco per celebrare un eroe. Ed è proprio di eroismo che bisogna parlare quando ci occupiamo di autori come Piscopo, eroi di una letteratura che enfatizza l’innovazione in una società delle lettere, cui appartiene Piscopo, che ormai tende a fare tabula rasa anche delle sue proposte migliori (nonostante la letteratura cosiddetta “tradizionale” da tempo marca una forte limitazione in una società di massa tecnologica ed avanzata che propone formule comunicative diverse sia estetiche che di contenuti), adulatrice di quei parametri “mercatoriali” in cui non c’è proprio niente di cui andare fieri.

Le prime volte che ho incontrato Ugo Piscopo lo devo a Luciano Caruso. Infatti, la prima volta (ma già conoscevo il suo alto spessore culturale) fu alla serata che gli amici napoletani (il pittore Mario Persico, lo stesso Piscopo, l’attore Renato Carpentieri, etc.) dedicarono a Caruso all’Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli, all’interno della sua mostra personale Scritture da viaggio, verso la fine di novembre 2002, un paio di settimane prima della sua morte, avvenuta a Firenze il 16 dicembre; la seconda volta fu alla Fondazione Morra, presso il Palazzo dello Spagnuolo, nel quartiere Sanità di Napoli, ma Caruso purtroppo non era più tra noi da circa un paio d’anni. In quell’occasione si presentò un suo volume, Xenia che curammo, nel 2003, io e Rosario Boenzi, in una co-edizione tra le Edizioni Riccardi (di cui ero il direttore editoriale) e l’Associazione Nazionale Socrate, di cui Boenzi era il rappresentate per la Campania. Il volume fu presentato l’8 aprile 2004 da Stelio Maria Martini e da Piscopo, con un intervento di Nerio Nesi, presidente dell’Associazione Socrate: una serata indimenticabile, con un folto pubblico e le straordinarie letture dell’attrice napoletana Antonella Stefanucci e del padre pittore Tony.
Vorrei ora qui ricordarlo ripubblicando uno scritto e un’intervista (Ugo Piscopo: poesia per linee dissacratorie e antiliriche) che pubblicai qualche anno fa sul magazine on line «Cinque Colonne», come se fosse ancora tra noi, con quel suo modo di fare pacato, di poche parole, mai sopra le righe, con modi garbati e gentili, e nonostante fosse di bassa statura e con un fisico gracile, era un vero gigante come pochi letterati lo sono, un giudizio il mio forse di parte, ma che è avvalorato dalla descrizione che ne fa Enrico Bugli, uno dei protagonisti dell’avanguardia napoletana ‒ e non solo ‒ pittorica e letteraria, sviluppatasi soprattutto negli anni ʼ60-ʼ70 del secolo scorso: «Interessante, di poche parole giuste e garbate sempre, serio, abbastanza chiuso, spesso quasi invisibile. Sorpresa! Martini lo conosceva dall’università e lo stimava (fatto in se raro). Da vicino, una persona mite, un elfo! Estremamente riservato, non parla che pochissimo, secondo me tace perché le cose cosi banali che si dicono non valgono la pena di una risposta. Di ciò mi sono, poi, data una ragione, Piscopo ha un curriculum scientifico da fare invidia a qualunque uomo di cultura fosse letterato, saggista o poeta, i suoi attributi sembrano illimitati. La curiosità cresce intorno alle persone come lui, così scoprii che oltre ad essere un fine letterato e questo in un mondo di improvvisati non ha prezzo, aveva un tono garbato non si dava arie e ne avrebbe avuto ben donde, inoltre trattava tutti alla pari senza spocchia. Da trent’anni non frequento inaugurazioni e gallerie, lo ritengo superfluo, si vedono e soprattutto si sentono e vendono sempre le stesse cose trite e poi da allora non sono più addetto ai lavori, mi è restato il fascino sottile della curiosità, questa mi risucchiò nella saletta della mai abbastanza rimpianta libreria Guida, per sentirlo parlare (finalmente), quando alla fine gli chiesi di dedicarmi la copia di Le Campe al Castello che avevo acquistato, ebbe un attimo e uno sguardo di esitazione, penso che forse volesse sottolineare l’ingenuità della mia richiesta, non so».
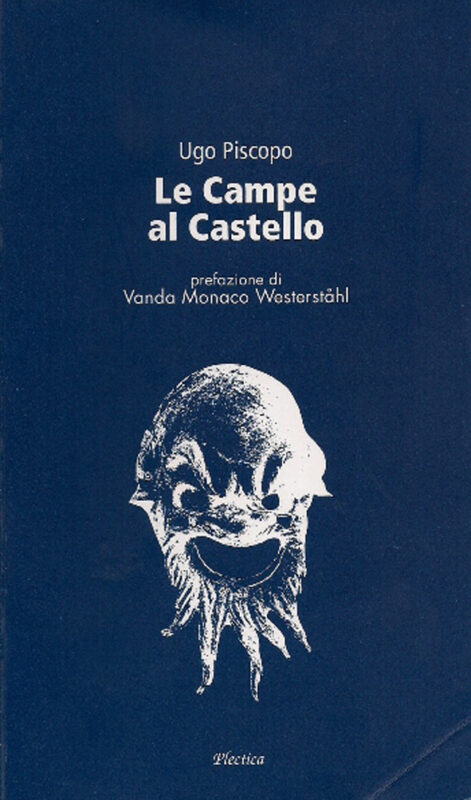
A Napoli ci sono scrittori e poeti che hanno ricevuto dalla città molto meno di quanto abbiano dato alla crescita della cultura partenopea e non solo partenopea. Uno di questi è stato Ugo Piscopo, poeta, scrittore, studioso di letterature moderne comparate, traduttore, critico letterario e d’arte, autore di teatro, nato a Pratola Serra (AV) nel 1934. È stato 4 anni in Africa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri (conoscendo anche il carcere, come riportato più avanti) e ha svolto un’ampia attività giornalistica (soprattutto su «Paese Sera»). Inoltre, si è impegnato in attività politiche e sindacali di base (consiglio di distretto, consiglio di quartiere, consiglio comunale). Dopo il percorso scolastico, con una laurea in Lettere classiche conseguita alla “Federico II”, discutendo la tesi col prof. Francesco Arnaldi (1957), iniziò ad insegnare materie letterarie in scuole secondarie, “vagabondando” tra Napoli, Lacedonia, Ariano Irpino e Tripoli (Libia) dove venne addirittura imprigionato per quattro giorni.
Nel 1967, dopo quattro anni nella capitale libica, alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, insegnando Lingua e Cultura italiana per stranieri c/o l’Istituto Italiano di Cultura, tenendo anche un corso di conferenze sulla poesia italiana contemporanea, fece ritorno in Italia e si stabilì con la famiglia definitivamente a Napoli.
Dal 1973 al 1984 fu nominato preside in vari licei e dirigente superiore per i servizi ispettivi del Ministero della Pubblica Istruzione fino al 2000. E per la scuola e la critica letteraria, discipline che gli danno una certa notorietà, cura vari testi di impianto interdisciplinare, letterario o narrativo (p. es. Antologia di cultura contemporanea, Ed. Palumbo; Noi e gli altri, con C. Salinari, id.; Paese sommerso, id.). Ha tradotto vari libri, ha fatto il critico d’arte, ha scritto alcuni volumi di narrativa, si è impegnato in attività politiche e sindacali di base (consiglio di distretto, consiglio di quartiere, consiglio comunale) e scritto testi teatrali. Dunque, la sua attività culturale e creativa si dipana su tre direzioni complementari: quella di critico, quella di poeta e quella di autore di teatro1.
Qui, quello che c’interessa è il Piscopo poeta che ha riscosso molto poco di quanto meriterebbe, e con questo scritto ci apprestiamo a tentare, con passo felpato, di far conoscere la sua poesia, coinvolgendolo alla fine in prima persona con una breve intervista.
Autore di numerosi volumi di poesia (Catalepta, Tipografia Artigianelli, 1963; “e”, La Provincia Editrice, 1968; Jetteratura, Lacaita, 1984; Quaderno a Ulpia. La ragazza in mantello di cane, Alfredo Guida, 2002; Haiku del loglio e d’altra selvatica verzura, id., 2003, in collaborazione con Gianni Rossi; Il ricordo del tempo di un bimbo che misura, La Città del Sole, 2006; Lingua di sole. 12 haiku + 1, La Stanza del Poeta, 2007; Presenze preesistenti. Pietre di Serra di Pratola Serra, Guida, 2007; Familiari, Oèdipus, 2011; fino a Crepitii Epitilli, id., 2018; passando per gli haiku di Oscilla mille, Ed. Empiria, 2013; e alcune prove di narrativa: La casa di Santo Sasso (Sellino, 1993); Scuola che sballo (Alfredo Guida, 1997); Irpinia sette universi cento campanile (ESI, Napoli, 1998); Torneador e i suoi amici (2001), non si spiega perché, nonostante vanti pregevoli pubblicazioni di poesia e uno spessore da far invidia a molti poeti che oggi vanno per la maggiore, Ugo Piscopo è “poco conosciuto” come poeta, spesso perfino dimenticato (ma sarebbe più giusto dire letteralmente ignorato) dai curatori di antologie editate al nord, destino e dramma comune a tanti altri autori non soltanto campani che hanno scelto di mettersi al servizio della parola senza attendersi (né facendo nulla in tal senso) di essere incoronati con l’aureola. Ma questo del monopolio “leghista” dei curatori del nord che hanno ignorato quasi sempre i poeti specialmente campani, è un altro discorso che andrebbe approfondito, ma in altri momenti.
Tralasciando le curatele e il nutrito lavoro di testi critici e scolastici ‒ come accennato più sopra ‒ di grande rilievo, soprattutto alla riscoperta di autori trascurati, dimenticati o di movimenti d’avanguardia (p. es. Alberto Savinio, Massimo Bontempelli, Vittorio Pica, il Futurismo ridandogli nuovo interesse2), per cui ha raccolto, giustamente, molti riconoscimenti e si è fatto “un nome”, il Piscopo poeta è tutto o quasi da scoprire (a tal proposito, sul prossimo numero di «Malacoda» pubblicheremo una piccola antologia di sue poesie, nel tentativo di contribuire a farlo conoscere un po’ più come poeta). «Lui ‒ come giustamente ha scritto in un post su facebook, all’indomani della sua morte Marco Palladini ‒ apparteneva a una generazione, i nati negli anni ʼ30 del XX secolo, che si è quasi completamente estinta negli ultimi anni. Uomini e intellettuali del Novecento, ultimi testimoni della migliore kulturkritik del Moderno»: Stelio Maria Martini, Mario Lunetta, Franco Capasso, Gianni Celati, Carlo Bordini, per fare qualche nome.

Ma di quanti altri poeti o artisti che sono passati a miglior vita, si avverte la mancanza? Pochi, direi. Forse perché nella maggior parte dei casi si tratta di poeti che non sono riusciti a lasciarci una grossa eredità: non è il caso di Piscopo che, nonostante come poeta sia ancora poco conosciuto al grande pubblico, possiamo affermare di trovarci di fronte ad una interessante poesia. «La “leggerezza” dello stile ‒ dirà Antonio Filippetti, a proposito di Familiari ‒ [in Piscopo] non è altro se non lo strumento che il poeta “s’inventa” per meglio interloquire con la società presente e soprattutto capire il senso civile e politico che domina nei nostri giorni»3.
Analisi critica della realtà (in particolare quella del rurale sud, in primis sulle orme di Scotellaro e Sinisgalli) e sperimentazione stratificata di una poesia fatta di rimandi, metafore, citazioni, tradizioni popolari, plurilinguismo, rime interne: è questo Piscopo, e molto altro ancora, ovviamente, un poeta che relaziona la parola con la realtà in cui vive, con la terra in cui vive, esternamente da sé. Non c’è intimismo o autobiografia nei testi di Piscopo: nella sua poesia tutto si fonde per una commistione ideologica e linguistica, onirica e immaginaria, atta a scuotere le coscienze invischiate in un processo industriale e progressista (si fa per dire!), dove l’uomo è sostituito dal consumismo odierno e da un mercato più vieto che rende merce persino il pensiero: come può opporsi il poeta a tutto questo? con l’unica arma di cui dispone: la parola.
Preciserà in una intervista rilasciata a Lorenzo Spurio lo stesso Piscopo, il suo rapporto col lessico: veniamo a conoscenza che non amava né il “classicismo” né il “modernismo”; «li tengo in sospensione. Non è perché mi facciano venire le allergie, ma ne faccio uso con estrema cautela. Ben altro è il rapporto con “classicità” e “modernità”, che sono referenti valoriali in cui credo». Soprattutto credeva nella forza dei loro scambi sinergici, «come ci hanno creduto nel Novecento Quasimodo e Sanguineti, Yeats, Eliot e Rilke, Savinio e Bontempelli, e prima ancora (andando à rebours) Baudelaire, Shelley, Keats e Byron, Goethe e Novalis e tanti altri». Era, insomma, uno che amava le sinergie, i lavori di gruppo, i movimenti sperimentali del secondo Novecento, anche se praticamente non aderì a nessun gruppo. Ci andò vicino con la neoavanguardia di cui fu compagno di strada, ma in totale autonomia. «Avrei dovuto essere a Palermo ‒ dirà ancora ‒ per la costituzione del Gruppo 63 e conservo ancora una cartolina di invito di Luciano Anceschi. Con Edoardo Sanguineti, c’è stata amicizia. Ha recensito dei miei libri, una volta per dodici settimana di seguito mi ha mandato una cartolina illustrata, ha scritto per una collana da me diretta un volume e, quando è scomparso, stava scrivendo un volume dedicato a Salerno sempre per la stessa collana». Dunque, uno sperimentalista, un avanguardista in “disparte”.

In Piscopo (soprattutto nel Piscopo di Jetteratura), l’opposizione deve realizzarsi attraverso una parola non intimistica né simbolica o protratta per forza verso una significazione, rimettendo tutto in discussione, anche se stessa, per riconoscere qualcos’altro tra le pieghe del reale («… “Non hai fede perciò queste tentazioni del deserto” / mi dici e non sai se ci giochi lo strazio del travaso / delle parole che usi come oggetti belli / da lustrare e disporre secondo i giorni e le stagioni / Non sai che gli oggetti hanno barbe e radici nello spazio / e le parole sono farfalle sotto vetro / e la memoria è un museo dove ogni cosa unica conservo…»4.
Poesia quasi gnomica ma surreale, questa di Piscopo, frammista ad un’autoironia del divertissement, nonché allo strazio e al dolore che la lotta all’ipnotismo di una imposizione di fasulle certezze si rassoda nel suo fare poetico. Una coscienza “rigenerata”, la sua, che risente fortemente, dunque, di una impostazione socio-politica, dove il linguaggio, “per linee dissacratorie ed antiliriche”, è sottolineato come fattore importante nella vita degli individui e della società (come insegna F. De Saussure), ma anche riorganizzazione del proprio tempo, dei luoghi della propria memoria, mai patetica; semmai smembrata, frammentaria, allitterata in una forma breve: «dui cilia quatto cilia sei cilia / sicilia silicia silicosi silicato // calabria calabritto caladritto / nel cratere di calasetta e calascibetta // sfoglia la pula che smaglia che sfoglia / la puglia le lune e gli sonagli // sotto lo sperone del gallo giallo come la puglia / la crapa crepa de la basilicata tutta bruciata»5.
Allitterazioni, dunque, sovrapposizioni e frammenti forzano il ritmo di un accumulo verbale antilirico; enjambement e non solo enjambement, anafora di grande tensione espressiva, paradossi dell’assurdo, mettono sul piano delle iniziative, nonostante qualche eco d’ispirazione alessandrino o tardo stilnovista, fatto salvo il ricorso alla matrice manieristico-barocca, non più il metodo ma i metodi, non più l’assolutezza ma la relatività, non più la verità ma le verità della scrittura, non già sulla strada dell’origine, ma sulla strada dell’uomo, nel tentativo di rendere possibile l’impossibile:
Se un seme
Irrefrenabile a ciascuna uscita
uno scirocco salino t’avvolge
e gonfia il cuore l’ombra d’una foglia
di platano tappezzato da fante americano
s’aggira tra i visi
e le parole allargandosi in mezzo
e cade a striscio tra larghe pareti
Ma se sull’umido musco si posa un seme
e la gemma spacca l’involucro
impazzito drogato il filo scoppia
in una vertigine verde
foglie di zucca si stendono al sole
espante con spessa e sciocca rozzezza di gloria
8 dicembre 1968
(da Jetteratura, op. cit., p. 72)
* * *
D. Come si muove un fine intellettuale come te, che si è speso e si spende su vari versanti culturali (critica, arte, scuola, riscoperta di movimenti e letterati – penso al futurismo, al surrealismo, ad Alberto Savinio, per fare qualche nome ‒) non legato alla cultura-spettacolo e/o mercimoniosa, nell’ambiente in cui vive, con distacco o come paladino di quella cultura seria, indispensabile per il vivere quotidiano?
R. Sono stato e sono sempre dalla parte della serietà, ‒ non della seriosità, che è ben altro. E forse sono ancora più dalla parte della serietà, quando scherzo, spesso amaramente, come, ad esempio, nella trilogia Le Campe al Castello? Il Signor Padrone e il suo misterioso Consigliori; La Bonifica ovvero Lit all’incanto. ‒ La comicità, spiegava Socrate nel Simposio, presente Aristofane, con cui egli dialoga per via diretta e per via indiretta, è tanto più sé stessa, quanto più ha consapevolezza del suo opposto, che è il tragico. Quanto più nasce di riflesso della contraddizione e ne tenta una messa tra parentesi, in sospensione anche se provvisoria. A prova che il mondo non è tutto una tragedia.
Certo, la serietà, quella vera, costa e te la fanno pagare. Ma questo è in premessa,viene sottoscritto dall’interessato nel protocollo d’intesa iniziale. Poi, lo stesso non ha più diritto di lamentarsi. Deve solo stringere i denti e andare avanti, qualunque sia il prezzo da pagare.
D. Qual è il tuo rapporto con Napoli, ossia con la città in cui vivi, le sue bellezze, la politica, etc.?
R. Il mio rapporto con Napoli e col Sud è stato di intensa partecipazione. Fino a ieri. Oggi, però, per gli acciacchi dell’età, devo procedere col contagocce: potessi fare-dare di più, ne sarei felice, ma non posso materialmente. Però, ci soffro. Ai bei tempi, ero in continuo conflitto con mia moglie, che si spazientiva di tutti quei miei impegni, nella scuola, al giornale, al partito (il PCI), al sindacato (la CGIL scuola), nelle case editrici, negli eventi artistici, nei dibattiti, nelle associazioni culturali, ‒ sono stato, tra l’altro il responsabile per la critica d’arte per Napoli di «Paese Sera» e l’ultima monografia d’arte l’ho pubblicata nel 2015, pesante di quasi due chili – e ogni tanto, non potendone più, mi ingiungeva: «Ma prenditi la branda e vattene al tuo Liceo, al tuo Giornale, al tuo Partito, perché lì è la tua casa. Vattene dove vuoi, le vie le sai, e non ti fare più vedere da queste parti. Tanto, qua che ci stai a fare? Solo per rappresentanza e per dare fastidio!»
D. Se avessi una bacchetta magica (perché ci vorrebbe una bacchetta magica per ripristinare un vivere socio-culturale che programmi una sana e laboriosa esistenza) cosa cambieresti di Napoli?
R. Mi terrei tutto di Napoli nella sua materialità, col Vesuvio, il Golfo e gli altri annessi. Con la clausola, però, di poter procedere a un risanamento totale a livello ambientale e urbanistico, dai fondali marini e dal sottosuolo avvelenato e intasato di ogni porcheria e di ogni avanzo alle strade al tessuto edilizio al verde all’aria, ridotta attualmente a uno shakerato di gas venefici. In quanto agli abitanti, beh, tutto sommato, me li terrei, anche se avrei voglia di tagliare “a tutti lo capo a tondo”, come diceva Cecco. Me li terrei, anche così come sono, nel bene e nel male. Ma una cosa fondamentale cambierei nella loro testa: che devono imparare a rispettare, non il boss o sé stessi al di sopra di tutto, ma la dignità della persona, a partire da sé stessi a terminare a tutti gli altri, belli o brutti, alti o bassi, maschi o femmine, vecchi o giovani, napoletani o non napoletani, sani o malati.
E devono, anche e ineludibilmente, assumere sempre e comunque il senso etico-civico della corresponsabilità sociale, della legalità, della trasparenza, della relazionalità corretta e costruttiva con l’ambiente, consapevoli che quel che c’è non è roba da arraffare, ma da potenziare e migliorare anche per le future generazioni.
D. Quali sono i programmi culturali che hai in agenda?
R. Non parliamo di “programmi”: il mio futuro ormai è alle spalle. Adesso, navigo sotto costa, a vista. E, a vista, ho alcune cose avviate e altre da avviare. Le avviate sono: 1. un volume di circa 350 pagine, di cui ho già corretto le prime bozze e che potrebbe uscire già fra un mesetto. È dedicato al teatro giovanile del periodo fascista, i cui protagonisti, tra il 1943 e il 1945, cambiarono orientamento ideale di centottanta gradi, magari abbandonarono del tutto il teatro e dintorni, per riconvertirsi in nuovi intellettuali e nuovi politici, ma, anche se parlarono e agirono in nome di altri referenti ideali, nella sostanza continuarono a usare quei moduli, quelle griglie ermeneutiche, quella foga inventiva degli anni del fascismo. A Napoli, questa vicenda riguardò autori come Luigi Compagnone, Anna Maria Ortese, Antonio Ghirelli, filosofi come Pietro Piovani, intellettuali e politici come Massimo Caprara e Giorgio Napolitano, di cui si riportano documenti e testi mai più ripubblicati o citati; 2. una raccolta di poemetti dal titolo “Epilli”, con prefazione di Stefano Verdino e postfazione di Vincenzo Guarracino, già consegnata all’editore; 3. un volumetto, a cura mia, di lettere e appunti dal fronte della Grande Guerra di mio padre, Gaetano, con prefazione di Francesco Paolo Casavola e postfazione di Marcella Marmo; 4. la stampa di una pièce teatrale dedicata a Francesco Cangiullo e alla sua “Piedigrotta”, andata in scena un centinaio di volte in più stagioni sotto la regia di Renato Carpentieri e nell’interpretazione della sua compagnia “Liberasceneensemble”.
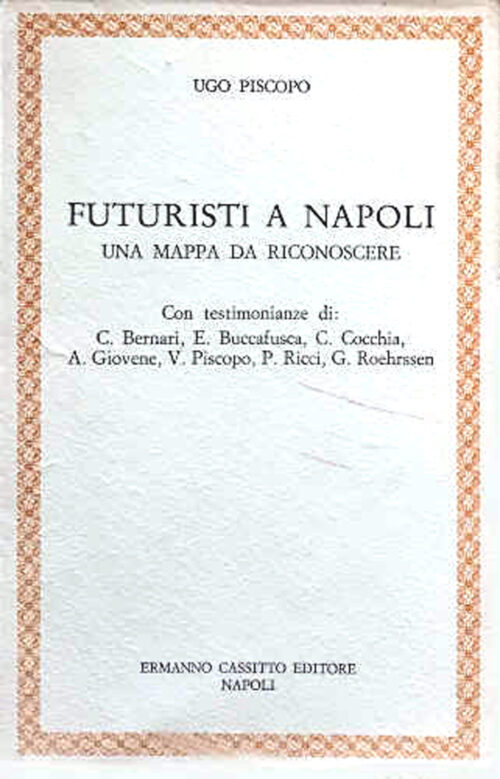
D. Tu che conosci abbastanza bene l’editoria napoletana, sai dirci perché è considerata la sorella povera di quella del nord (Feltrinelli, Mondadori, Einaudi, Marsilio, etc.), per non parlare degli scrittori e poeti locali del calibro di Franco Cavallo, Felice Piemontese, Michele Sovente, Antonio Spagnuolo, Ciro Vitiello, Alberto Mario Moriconi, tu stesso, che hanno poco o nulla da invidiare al resto d’Italia ma che puntualmente vengono esclusi dalle antologie pubblicate dai vari Mondadori, Einaudi? Facciamo riferimento, una per tutte, all’antologia di qualche anno fa, Poeti del secondo Novecento 1945-1995 (Mondadori, 1995), curata da Maurizio Cucchi e Stefano Giovanardi, più che un’antologia, la definirei una “combine nordica”.
R. L’editoria napoletana è, oggettivamente, non comparabile con quella del Centro-Nord, per quantità di prodotti, per qualità, per capacità di persuasione. La colpa non è di Napoli, ma della mentalità a cui si ispira e dei modelli organizzativi. E non è del Sud. A Napoli, infatti, quando si è voluto fare qualcosa di buono, lo si è fatto. Esemplare è la vicenda della Casa Editrice Riccardo Ricciardi, cresciuta all’ombra della presenza e dei suggerimenti di Benedetto Croce. Partita in maniera modesta, grazie alla coerenza dell’indirizzo culturale e della serietà dei prodotti, si è infine affermata con un suo profilo di affidabilità e di unicità, tanto da essere accolta dalla Mondadori ed essere esibita come un fiore all’occhiello per tutta la cultura italiana, col bel nome di “Ricciardiana”. A Napoli, abbiamo avuto anche esperienze da tenere presenti su questo orizzonte di attesa, delle Case Morano, Loffredo, Guida, Liguori. Nel Sud, poi, abbiamo tante altre vicende degne di rispetto, come innanzitutto quella della Laterza di Bari e ora di Roma-Bari, o quella della Sellerio di Palermo, o quella della Rubbettino in Calabria. In questione, dunque, non sono Napoli e il Sud. Il nodo dei problemi in negativo dell’editoria meridionale è stato ed è costituito dall’occasionalismo, dall’assistenzialismo, dall’improvvisazione, dal modello del bancone “qua il libro, qua i soldi”, dalla mancanza di imprenditorialità negli investimenti, dalla debolezza dei progetti, dalle gelosie localistiche, dall’incapacità a creare e a diffondere la propria immagine. Da ciò, non possono non scaturire conseguenze anche sul profilo dei nostri autori.
D. Ci parli un po’ del tuo ultimo lavoro letterario, la riscoperta del poeta francese Victor Segalen, del quale hai curato tradotto e prefato Peintures (Oedipus, Salerno, 2015), una delle opere maggiori di Segalen, poeta che non conoscevo e grazie a te ora ho una conoscenza in più nel campo letterario?
R. Quest’ultimo lavoro mi sta dando molte soddisfazioni. Mi hanno scritto o ne hanno scritto entusiasti Mario Richter, Silvio Ramat, Stefano Lanuzza, Paolo Lagazzi, Felice Piemontese, Silvio Perrella e altri. A questo lavoro, ho pensato da tanto tempo. Ma ho dovuto dare priorità ad altre ricerche. Comunque, ogni volta che mi fermavo a riflettere sulle origini e gli svolgimenti del moderno, prima o poi mi imbattevo nella figura e nell’opera di Victor Segalen, che andavano conosciute meglio. E, con la mia traduzione, ho voluto dare un contributo, per quanto potessi, a far conoscere l’originalità, l’inventività, la sperimentalità attualissima di un autore proiettato ad andare oltre i modelli culturali dell’Occidente e a interrogare le interrelazioni linguistiche fra pittura e poesia.
D. Dall’alto della tua esperienza letteraria, le nuove generazioni sono in grado di opporsi all’illegalità e alla mancanza di cultura, in grado di programmare il loro futuro a dimensione umana o a cosa sono destinati?
R. È, questa, una domanda da un milione di dollari. Potrei dire quelli che sono i miei auspici, ma non quello che può essere lo svolgimento del nostro tempo nel concreto. Gli stessi addetti alle previsioni, se per il passato hanno spesso sbagliato, oggi si trovano a dover fare i conti con eventi e situazioni inediti nella storia, le cui conseguenze non sono perfettamente calcolabili. La possibilità oggi del sistema di controllare e orientare strumentalmente opinioni e coscienze di tutti e in particolare dei giovani è mostruosamente in crescita. È innanzitutto questo quello che dovrebbero sapere i giovani e cercare di salvaguardare sé stessi dall’essere adoperati e ridotti a semplici, passivi utenti, ognuno felice di scegliere la propria schiavitù.
D. È ancora possibile pensare di realizzare, a Napoli, una letteratura come l’avanguardia degli anni ’60-’70 che evidenziava la vacuità dell’esistente con prese di posizioni radicali e innovative, dei vari Luciano Caruso, Stelio Maria Martini, Mario Persico; la ricerca astratta di un Renato Barisani in pittura; o la spinta in avanti delle riviste «Documento-Sud», «Linea Sud», «Continuum», «E/man/azione», «Uomini e Idee»?
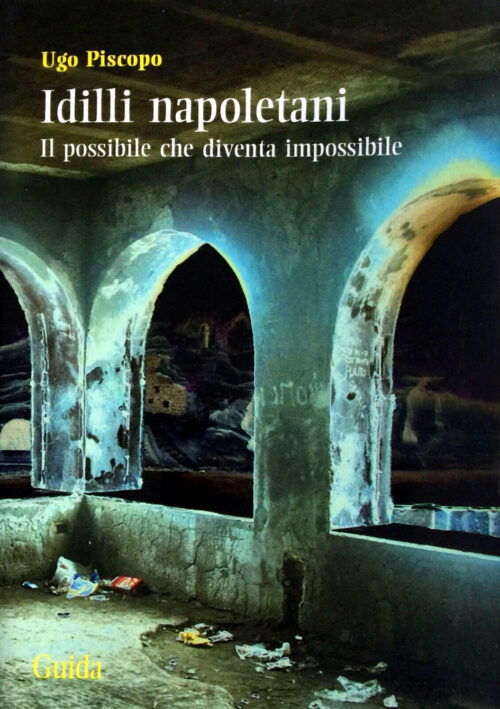
R. È possibile, anzi necessario, andare avanti. La modernità e la postmodernità sono degli acquisti essenziali e fondamentali, sebbene tanti e in tante maniere, dalle banali alle meno banali, tentino di pensare, di dire e di fare, come se niente fosse successo. Vogliono tenere gli occhi bendati. È una loro scelta. Andare avanti, però, non può significare epigonismo e scolasticismo. Oggi bisogna ripensare e rifondare, ad altezza delle attese e delle potenzialità dei nuovi tempi, la nuova poiesi. Bisogna esporsi al tormento del dubbio e della ricerca e al rischio di fallire. Occorrono, come sempre, agonismo e coraggio.
D. I dibattiti sulla poesia e sulla letteratura in genere, che pur si sono tenuti in questa città – contrariamente a quanto si possa pensare e credere –, non sono riusciti a contrastare la supremazia di un livello mediocre e restaurativo. Anzi, hanno accentuato ancora di più quello che già si prospettava da tempo; e cioè che la cultura napoletana (certa cultura, almeno) ha una spiccata propensione a bearsi nel riconoscimento, nell’“applausometro”, nei lineamenti di una tradizione ormai fuori tempo, piuttosto che farsi carico di una proposta di mutamento. Nessuno vuole assumersi tutti i rischi che un mutamento radicale e impegnativo porta in superficie, in questo contesto storicamente deviante, antropologicamente “infetto”, fisiologicamente anchilosato. Secondo te, come se ne esce?
R. Certo, oggi nel mondo i livelli di estetizzazione, di spettacolarizzazione, di banalizzazione, di alienazione dalla drammaticità del reale si vengono alzando, col concorso di molteplici fattori. A Napoli, questi processi si fanno più policromi, rumorosi, sensualmente avvolgenti. Ma non tutto va verso questa direzione. Ancora oggi, nelle arti (musica, pittura, scultura, poesia, cinema, teatro), negli studi sia umanistici, sia scientifici, si sta costruendo del buono, degno della grande tradizione che va dal Pontano e da Giordano Bruno a Vico, agli illuministi, a De Sanctis, a Croce e oltre. Bisogna resistere e procedere nelle ricerche, anche se attorno la confusione cresce.
Un grazie a Ugo Piscopo per la grande cultura che ci ha lasciato in eredità, sperando che non sia dimenticata. Chiudiamo questo ricordo con un acrostico che Giorgio Moio dedicò all’amico Ugo, pubblicato nel volume Contrappunti variabili. Poesie con dediche 1986 – 2019 (Bertoni editore, 2020):
Un movimento curvilineo
(per Ugo Piscopo – 2019)
U n movimento curvilineo dei corpi a sollecitare la materia che
[avvolge le cose
G overna le proposte in acque agitate si fa forma il fare a 10
[gradi fahrenheit
O rmai sono anni che non s’inventa nulla ca ʼo pappece nun
[spertosa
P erò possiamo farla come cazzo ci piace sta sfaccimm ʼe poesia
I n pigiama party o in maniche di camicia na festa ʼe culori arrapati
S enza versarci camomilla int’ ʼe percoche e si sta in attesa che
[partano gli storni
C hi ci mette na cresommola n’aglio aglialluto un grido trivellato
O poco ʼe pepe ʼngialluto un ditalino di varechina un piscio di
[pipistrello
P oi un giorno un giorno qualunque da una strada buia spunterà
[un’ombra
O nda che si apre una via nella darsena ’nzuppata ’e pocrisia
[scovando la meraviglia
_______________________