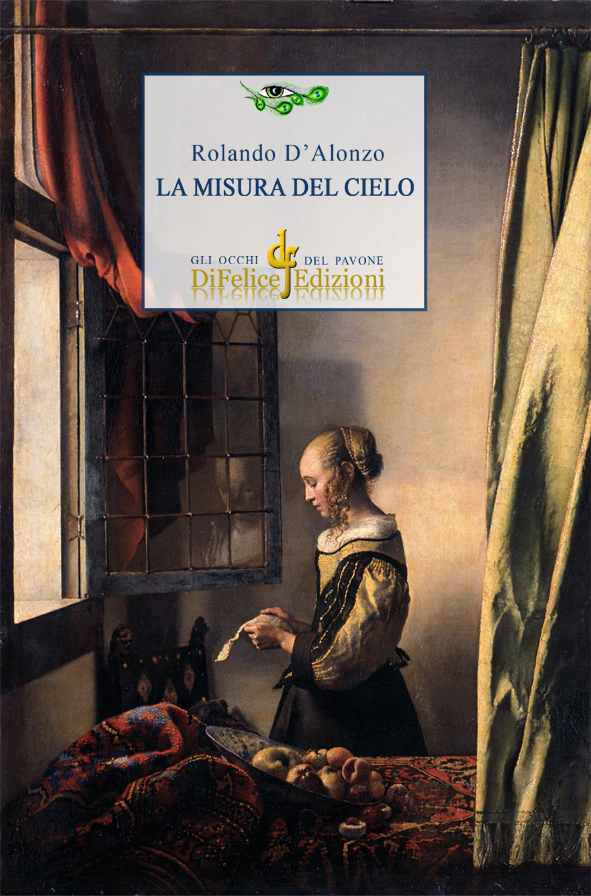 Non per tutti l’esistenza è un’esperienza semplice o gradevole. La paura di affrontare la vita, alcuni l’avvertono così prepotentemente che cercano di liberarsi da quell’assillo, tanto da affidarne il pungolo ad altri, della cui vita divengono partecipi spettatori, estranei alla propria di cui evitano l’impatto per non ridursi come ectoplasmi gravati da un incubo che si ripete nelle forme di una quotidiana vessazione, di una perniciosa condanna.
Non per tutti l’esistenza è un’esperienza semplice o gradevole. La paura di affrontare la vita, alcuni l’avvertono così prepotentemente che cercano di liberarsi da quell’assillo, tanto da affidarne il pungolo ad altri, della cui vita divengono partecipi spettatori, estranei alla propria di cui evitano l’impatto per non ridursi come ectoplasmi gravati da un incubo che si ripete nelle forme di una quotidiana vessazione, di una perniciosa condanna.
Analoga situazione è quella che coinvolge lo scrittore, il quale, per ottemperare alla sua vocazione, deve necessariamente dar vita a un fantoccio, a un personaggio e sostenerne le vicende, e renderlo credibile, coerente con se stesso, impedirgli passi falsi e contraddizioni, vestirlo ogni giorno e nutrirlo, premuroso nei confronti del suo personaggio così fragile e inconsistente a cui affida la propria capacità di immaginare, istigandolo a compiersi, a essere, a ingrassare a colpi di finzione, in un tortuoso e angosciante percorso.
Tra l’inetto, che delega un altro individuo alla vita, e lo scrittore che dà vita a un fantasma, la distanza è breve, lo stesso filo li regge entrambi, forse è questo il motivo per cui in alcuni romanzi i protagonisti si scoprono disadattati, disagiati, solitari, esclusi, emarginati, eccentrici, misantropi, asociali, mentre in altri appaiono abbigliati sotto le mentite spoglie di una figura eroica pronta ad affrontare la vita, per sfida o per rivolta, con sprezzo, con coraggio e audacia, indici di una visione “romantica” della giovinezza, ritenuta l’età dell’avventura e della scoperta, dell’energia, della forza.
Questi casi umani e romanzeschi implicano entrambi una lettura verosimile dei fatti, pur sempre approssimativa, o convenzionale. Nulla autorizza a escludere che la realtà possa al contrario costituire una lunga ininterrotta serie di mistificazioni, in base alla quale lo scrittore, obbligato a continuare la trama degli inganni, la esporrebbe nel genere più adeguato, quello teatrale della commedia o della farsa o della tragedia.
Se invece si dovesse approvare l’affermazione husserliana secondo cui l’eccellenza dell’espressione e dell’esteriorizzazione si realizza a pieno non nel dialogo, bensì in un monologo assoluto in cui la coscienza non si allontana in alcun modo da se stessa, le forme di scrittura più credibili sarebbero i monologhi, i diari, le autobiografie, e la letteratura si mostrerebbe per quel che è: l’incapacità di accettare la vita così com’è, il tentativo di deformarla, di riformarla, di migliorarla, di completarla, di aumentarla, di annullarla, di trascenderla, annullandone la potenza in un segno, simbolicamente.
L’inetto non vive, lo scrittore riconduce la vita alla sua verità intrinseca, la finzione, e la costringe a misurarsi su un piano diverso, a porsi di fronte a uno specchio deformante in cui l’alterità che la costituisce, il suo senso, quello che proditoriamente si nega all’uomo e gli sfugge, per un attimo rifulge, nel riflesso. In verità, è lo stesso scrittore a restare incantato del doppio sguardo della vita, che rende possibile perfino la sua finzione, e anzi in lui la sollecita a rivelarsi (a svelarsi e a velarsi doppiamente).
La doppiezza della vita è nelle mani dell’inetto e dello scrittore, che ne trattengono l’ambiguità, osservabile per mezzo di una sorta di specchio o di una lente che ne cristallizza il sortilegio di coscienza universale sminuzzata in molteplici sfaccettature, forse componenti di un unico messaggio.
Rolando D’Alonzo è accecato dalla ricerca del vero o meglio dell’ipocrisia che si mimetizza nel gioco di rapporti che costituisce la comunità sociale del suo tempo, la comunità che rinuncia al comunismo in nome dell’individualismo più sfrenato, a cui ci si ribella sprofondando in un ritorno al caos, all’indistinto, scegliendo la via di un anarchismo fortemente critico. Un atteggiamento che ha contagiato pochi scrittori, casi isolati nella storia della letteratura del Novecento, scrittori ai quali non sono spettati riconoscimenti o pagine nelle antologie della storia letteraria, forse perché non è stato possibile ricondurli a tendenze, a movimenti, a scuole, ovvero agli estensori di una visione media orientata dall’ideologia dominante, corroborata dalla critica ufficiale, sostenuta dall’imprenditoria editoriale; scrittori che sembrano non appartenere alla storia letteraria del loro Paese.
La loro unica religione è stata quella della letteratura e, in subordine, quella della verità, religioni poco professate e imbarazzanti, elitarie e non necessarie, scomode e portatrici solo di illusioni e di utopie anziché di certezze e di speranze.
Di altre religioni è piena la società, di religioni a portata di mano, professabili da chiunque, accettabili, consolatorie, rassicuranti.
Che cosa hanno a che fare con la storia letteraria italiana i romanzi Giù la piazza non c’è nessuno di Dolores Prato o Horcynus Orca di D’Arrigo? Da dove sono spuntate queste recherches del tempo perduto e di lingue perdute, senza alcun precedente, senza riferimenti se non quelli che lo stesso scrittore detta all’interno del testo?
Che cosa sono i racconti di Cancroregina o de Le labrene di Landolfi o de Il ricordo della Basca di Delfini? Quale linguaggio esplicano, quale tema raffigurano? A quale società, a quale stagione o periodo sociale si riferiscono?
E come si permette Luciano Bianciardi nel capolavoro La vita agra di criticare un sistema, svelandone tutti i meccanismi, con un’analisi degna di un anatomopatologo che nel 1962 trascrive un’opera profetica, pienamente realizzata ai nostri giorni?
Sembrano scrittori di un Altrove, di un reale che a noi non è dato conoscere ed apprezzare, cittadini di uno Stato che non è mai esistito, e che da lontano può sembrare il nostro, ma è solo un miraggio: la letteratura è essa stessa un Altrove.
Ed è accanto a queste voci isolate di scrittori, che testimoniano l’appartenenza a un mondo migliore di quello che gli uomini riescono a elaborare e a generare, voci di abitanti di un paradiso artificiale in cui si può fare a meno delle droghe per avere allucinazioni e iperolfattismi, e intattilità, ed è accanto a questi miniaturisti dell’Altrove che si pone, nel romanzo La misura del cielo(1), Rolando D’Alonzo, autore di un lungo meditato monologo in cui il protagonista narra la sua storia di giovane emigrato che, abbandonato un paese del Meridione per cercare fortuna e lavoro all’estero, torna in paese, povero come prima, libero e consapevole dell’incurabile male oscuro degli uomini, per citare Berto e il suo capolavoro, che con D’Alonzo condivide la tecnica di una scrittura interiore, consistente in un vero e proprio flusso di coscienza (stream of consciousness) dinamico e propulsivo.
Personaggio da romanzo, prima che scrittore, mestiere riflettente la propria sorte, Rolando D’Alonzo è un’icona letteraria, un punto di riferimento per gli scrittori abruzzesi e per il confronto delle idee libere e non asservite ai giochi di potere.
Con La misura del cielo D’Alonzo ha scritto il capolavoro che tutti attendevamo, che pretendevamo da lui – l’Infingardo, che teneva nascosto questo libro lasciato macerare negli anni in un cassetto, a dispetto e all’insaputa di noi che ascoltavamo attenti i suoi discorsi, adusi alle sue improvvise e teatrali menate, sovente travolti dalle sue polemiche, affascinati da acute osservazioni, divertiti dalle sue convinzioni poco coerenti sempre superate dalla successiva, soggiogati dalla sua cultura e dalla sua libertà, da una prorompente vitalismo che lo costringevano e lo costringono a un nomadismo non solo del pensiero, delle opinioni, delle idee, ma soprattutto dell’animo: noi lo eleggevamo voce dei nostri silenzi, dei nostri consensi e dissensi, e soprattutto lo avvertivamo un po’ come l’eroe che parlava in nostro nome, per nostro conto, contro tutte le forme di potere, di organizzazione umana, contro tutte le ipocrisie, le violenze, la cattiveria, contro l’avidità ben nascoste nei volti dei nostri simili e nelle fondamenta delle loro istituzioni.
Ebbene, in questi casi la letteratura può diventare il luogo libero del discorso, il rifugio entro cui far fluire e rendere concreta tutta una vita spesa all’insegna della libertà, dell’anarchia, della fede abbracciata poi respinta o rimossa; delle sconfitte, delle cocenti delusioni, dell’emarginazione, che costituiscono le dirette conseguenze di un mancato allineamento o di uno spettrale, lugubre asservimento, in cambio della rischiosa scelta di aderire a un rigoroso rispetto della libertà interiore.
Rolando è il fratello maggiore che istiga alla libertà, alla ribellione, allo sperpero della giovinezza, a diventare se stessi prima che a divenire elementi amorfi della società civile, che infine sollecita alla pratica costante e quotidiana dell’affabulazione polemica, vivendola sulla propria pelle e nelle più esplosive contraddizioni, prima di ridurla a testo letterario o a favola o leggenda.
Chi spende la propria esistenza per viverla fino in fondo rischia di non riuscire mai a tradurla in letteratura, ritenendola una sorta di avvilente e pedagogica riduzione implicante necessariamente una morale, una visione del mondo egocentrica, un indebitarsi con le regole e con i compromessi sociali e civili; chi vive e pensa di vivere fino in fondo la sua esperienza, forse, sta già facendo vera letteratura, con il suo corpo, con la sua mente, con il suo modo di agire, e perciò non può specchiarsi in quella, né può pronunciarla o evocarla per renderla in una forma leggibile, giacché la vita non ha forma, ma può, se rispecchiata, sfoggiare solo lo stile che noi siamo, e lo stile non può essere narrato, la consapevolezza ucciderebbe Narciso.
Nonostante tutto e in barba a queste premesse logiche, Rolando ce l’ha fatta. È riuscito a scrivere il romanzo della sua esperienza esistenziale, trasformandola – non sublimandola – nella storia di un alter ego, che assume su di sé la colpa di aver scelto la strada quale maestra di vita e della propria libertà personale.
Se ne La vita agra (secondo quel che lo stesso autore afferma) «il protagonista è il narratore coinvolto nel suo narrare proprio in quanto narratore», similmente ne La misura del cielo si stabilisce un misurato equilibrio tra la finzione narrativa e il racconto autobiografico, in una lunga confessione, in un colloquio con se stessi che costringe il lettore a identificarsi con la coscienza del narratore, e dunque a interpretare le vicende e a riflettere proprio come lui, fatta eccezione per quegli avvenimenti e vicende in cui il protagonista assume comportamenti non sempre condivisibili.
Attilio Saraceni, Ilio per gli amici, emigrato in Germania, stalliere in un ippodromo, risiede ad Amburgo, in una sistemazione “assai confortevole”, dove ritiene di “aver portato a buon fine” il suo pellegrinare, grazie a un paese che lo ha accolto “a braccia aperte, senza riserve”. La sua figura non è descritta fisicamente, ma per richiami colti e icastici: «Il mio, il profilo incerto di un Pizarro, il quale, molto prima che suoni la mezzanotte, abbandona lo sgabello e il posto sfortunato di una interminabile partita a carte, si alza deciso, esce dalla tela e si lascia condurre dallo slancio dei muscoli verso altri luoghi». Si tratta di una descrizione originale che, tramite la citazione colta, nella suggestione dell’immagine pittorica grazie a cui viene suscitata la descrizione fisica del personaggio, sceglie una soluzione volta a accendere la curiosità e la fantasia e a offrire spazio all’elaborazione di un disegno interiore da parte del lettore, al fine di inquadrare e sottolineare la condizione psicologica del protagonista, piuttosto che a produrre elementi utili a individuare le caratteristiche fisiche e fisiognomiche di Ilio.
Nel prosieguo della storia, scopriremo che Ilio conduce una vita al limite della moralità e della legalità, inseguito da creditori mafiosi, che lo costringono a nascondersi. Miria, la donna da lui sempre amata ma andata in sposa poi a un altro, improvvisamente si ripresenta da Ilio, svelandogli di essersi separata dal marito. La storia d’amore finalmente si compie tra di loro, senonché la donna si ammala gravemente. Ilio, sempre più disperato e solo, vaga alla ricerca di denaro per provvedere alle cure della donna.
Per adempiere a un compito affidatogli da Miria, Ilio tornerà in Italia, dove ancora perdura una situazione identica a quella che lo aveva spinto a emigrare.
In una narrazione nervosa, frutto della coscienza agitata e del pensiero ansioso e sempre vigile del protagonista, si sciolgono la sua insopprimibile sete di avventura, il suo senso di libertà, i nodi della condizione dell’emigrato e dell’eterno esiliato, del pellegrino in terra. La carica vitale di Ilio non si esaurisce mai, rendendolo però vittima di una tensione che giunge fino allo spasimo, e che si quieta solo in pochi momenti.
Il vero protagonista de La misura del cielo è comunque il viaggio, il percorso che il protagonista compie per nascondere un’alterità forte e per renderla docile al racconto che si svolge davanti ai nostri occhi ad illuminare una metafora della vita: quel che conta e che guida i passi del protagonista, è un riferimento spaziale, la Distanza, ovvero la misura del cielo, il riferimento astrale per eccellenza, ciò che ci rende cosmicamente umani e che solo gli anarchici, i folli, i poeti, i mistici, gli iniziati, i maghi, i nomadi, i circensi e pochi altri determinano giorno per giorno, nel cuore, nell’animo, nei gesti che sono sempre riferiti a quella misura aurea.
L’autore predica il fallimento di una società essenzialmente ferma, incapace di muoversi, patriarcale anche nella modernità, dove il patriarcato diventa il potere politico ed economico, e la società si concentra sul commercio, sul mercato, sul profitto, sul denaro. Occorre un paradigma culturale diverso, che superi l’antropocentrismo e recuperi il nomadismo e ponga al centro tutti i fenomeni vitali e ambientali: in tal senso il romanzo di D’Alonzo appare come uno dei primi romanzi italiani a preconizzare l’avvento di un nuovo pensiero interessato a rinnovare il rapporto dell’uomo con il mondo e a decretare la fine della civiltà occidentale. Soltanto una cultura ecocentrica e antispecista potrà salvare l’uomo dalla sua estinzione.
Nell’opera ci sono pagine di inenarrabile bellezza e suggestione, pagine degne di antologia, in cui Ilio si abbandona a riflessioni critiche nei confronti del consesso umano e civile. Cito la pagina in cui viene nominato per la prima volta il titolo del romanzo: «Attraversai le strade del centro, stregato dall’idea della fuga, della liberazione, della morte solitaria. La vecchia signora con la veletta mi avrebbe condotto per mano in quel pezzettino di terra dove l’unica misura del cielo è il rettangolo della finestra da cui hai osservato il mondo la prima volta. Come seguendo una rotta ortodromica mi sarei ritrovato là dove avevo mosso i primi passi e sognare di diventare un uomo libero, un uomo che non teme le avversità, il dolore, il tradimento degli affetti, uno che ha bisogno solo della coscienza pulita e della voglia di viaggiare. Sarei stato un conoscitore dei crocicchi della vita meglio di qualunque altro mio compagno, più di qualunque individuo stanziale e soddisfatto. Ecco, un marinaio senza desiderio di tesori, un rom amico di tutti i rom perseguitati, un migrante come i migranti imbrogliati, sedotti dalla propaganda infine sfruttati fino a morirne, Ecco, tornare a essere un pugno di memorie che si apre al vento, un’orma di cammino persa nelle sabbie di tutte le anse delle mie stagioni infelici. Cambiare gli occhi, cambiare le orecchie e, con un nome qualsiasi, andare incontro al sogno della vita sul vetro del finestrino di un treno in partenza dalla Stettiner Bahnohf… o a un altro sogno che saluta, convalescente fantasma di me stesso, adolescente temerario e avventuroso, dalle vetrate del ponte di terza classe di un piroscafo che lascia gli ormeggi a Bremerhaven, affrancato da tutti gli affanni, da tutti i debiti, da tutte le usure delle usure…» (1).
E più avanti: «Tutte le città, tutti i palazzi, tutte le fortezze, i negozi, i teatri, gli idoli e gli arsenali sono costituiti sull’inganno: valgono meno di un pugno di calcinacci di fronte all’unica città dell’uomo, edificata nel vento del deserto, sulle acque del Tigri, dell’Eufrate, del Giordano, sulla roccia impalpabile dello spirito. La città umana è fatta per i templi, i templi sono fatti per il dominio, per la paura, per la compravendita. Soltanto i mercanti possono sentirsi a loro agio dentro una città e questa città dovrà essere sempre più vasta, più popolosa, più potente. Gli uomini non possono morire in pace dentro una città, perché la loro vita lì dentro è stata comprata e lì dentro è stata venduta. E anche la loro morte è stata comprata, è stata venduta. In città questo si può fare, tutto si può fare nella città mercantile: vendere l’inferno, vendere il paradiso, vendere la terra, vendere il cielo e le stelle e perfino vendere niente. Questo è lo spirito dei tempi» (2).
Si leggono pagine indimenticabili sul paese di nascita, avvertito come una persona, che sente come un essere vivente, oppure sul “sistema Italia”, su una società italiana basata sullo scambio di favori, clientelare e familistica.
Il ritorno alle origini non è quello vittoriniano, Ilio fugge di nuovo, ma il suo destino è quello di un eterno viaggiatore in pena, per il quale “non ha più senso capire” e quel che conta sta nei «riflessi della luce sulle imposte, certi messaggi criptici sui muri degli androni» (3).
Bisogna recuperare la vita e il rapporto con la natura se si vuole continuare a raccontare la storia dell’uomo.
________________________
(1) pp. 68-69.
(2) p. 96.
(3) p. 9.
Rolando D’Alonzo La misura del cielo De Felice Edizioni, 2019, pp. 341.