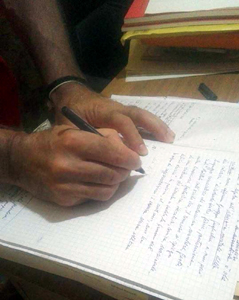 Quale poesia sorregge l’urto di una disfatta nel villaggio globale? A questo punto, un’altra domanda sorge spontanea: quale poesia può affrancarci dalla mortificazione dell’appiattimento culturale di questi ultimi anni? Non è semplice rispondere, in quanto la poesia in circolazione oggi – quella spettacolosa e rissosa dei talk-show e delle riviste patinate – è costituita da un’assenza di linguaggi critici, da una fissazione innumerevole di pratiche evanescenti: vive svuotata di ogni carica propulsiva. In questo villaggio globale (che assume sempre di più i connotati del proprio orticello), dove ci si intestardisce nel mantenere un marketing sempre più redditizio a qualunque costo, la poesia, confinata nell’anonimato come oggetto di una valutazione volutamente superficiale ed inutile al sistema degli affari, è costretta alla non-esistenza, a sistemarsi, in assenza di problematiche che rifuggono dal deja vu e dalla pacificazione culturale, nella nicchia dell’indifferenza. Per cui, è costretta ad autogestirsi (ancora una volta) in un mondo dove si vende il proprio “mestiere” di poeta al miglior offerente.
Quale poesia sorregge l’urto di una disfatta nel villaggio globale? A questo punto, un’altra domanda sorge spontanea: quale poesia può affrancarci dalla mortificazione dell’appiattimento culturale di questi ultimi anni? Non è semplice rispondere, in quanto la poesia in circolazione oggi – quella spettacolosa e rissosa dei talk-show e delle riviste patinate – è costituita da un’assenza di linguaggi critici, da una fissazione innumerevole di pratiche evanescenti: vive svuotata di ogni carica propulsiva. In questo villaggio globale (che assume sempre di più i connotati del proprio orticello), dove ci si intestardisce nel mantenere un marketing sempre più redditizio a qualunque costo, la poesia, confinata nell’anonimato come oggetto di una valutazione volutamente superficiale ed inutile al sistema degli affari, è costretta alla non-esistenza, a sistemarsi, in assenza di problematiche che rifuggono dal deja vu e dalla pacificazione culturale, nella nicchia dell’indifferenza. Per cui, è costretta ad autogestirsi (ancora una volta) in un mondo dove si vende il proprio “mestiere” di poeta al miglior offerente.
In questa dimensione distorta del pensiero creativo, la ricerca di nuovi moduli vivibili ed abitabili si certifica o con disegni criminosi o con azioni pacifiche: in entrambi i casi a garanzia della vendita di un prodotto scaduto, tautologico ed ipnotico. La cosa che più spaventa, lasciandoci disarmati, è che tutti vogliono entrare nelle classifiche dei best-seller, di essere riconosciuti “grandi poeti”, senza votarsi al sacrificio, senza la consapevolezza di dire qualcosa di diverso dall’inutile poetese melenso e intimista. E non è solo una questione riguardante le nuove generazioni; tutti si preoccupano, a prescindere dall’oggetto del contendere, di prendere parte allo spettacolo, di salire sul carrozzone del circo mediatico in questa parte di universo dove – per dirla con il compianto Franco Cavallo attraverso il suo Complesso e mutamento (editoriale dei numeri 6-7-8- di «Altri Termini») –, quattro anni di demo-craxismo prima, e un quindicennio di demo-berlusconismo poi – aggiungiamo noi –, hanno creato una sorta di movimento à rebours le cui conseguenze forse ancora non siamo in grado di valutare. E chissà per quanto tempo ancora ci accompagnerà questo modo di fare sistematicamente “torbido” che ha ridotto la poesia, la letteratura in genere, ad un cumulo di mondezza: anziché farsi portavoce di un progetto che ci aiuti da affrontare con forza intellettiva le problematiche dell’esistente, si cerca di quantificare il prodotto in base alle imposizioni di mercato delle grandi majors dell’economia e dell’editoria, e venderlo a prescindere dalla qualità. È con queste prerogative che la cultura si fa corteggiare dal giogo del potere dove l’affermazione del significato è la regola principe, una regola con effetti devastanti e talora irreparabili anche nei confronti di quella cultura votata alla negazione, alla destabilizzazione dell’effimero e dell’inalterato.
Dunque, detto ciò, quale poesia può affrancarsi dalla mortificazione dell’appiattimento culturale? Per quanto mi riguarda essa può affrancarsi – o tentare di affrancarsi – con la pratica del frammento (come ebbi a dire altrove in anni addietro), in quanto il frammento è capace di creare vitali situazioni da opporre a:
- a) all’io lirico: il frammento concepisce la comprensione storica, il rivivere le pulsazioni della memoria nel presente attraverso un io pratico;
- b) all’assolutezza dell’arte: il frammento, proprio perché frammento, cioè portatore (o costruttore) di altri testi o versi incompiuti e forse incompiutabili, abbandona l’elemento assoluto della storia che diventa per esso oggetto di una rivalorizzazione dell’arte stessa per cui non più il vuoto, cioè l’assoluto, determina la scrittura o la vita, bensì la rivalorizzazione di esse. È come dire, in buona sostanza, che il frammento alimenta non più la verità ma tante verità, tante molecole creative che vengono affrancate per essere “imbrigliate” – con la consapevolezza del tempo in cui nascono – in una nuova coscienza (continuità della storia) e affrancate (frammentate) nuovamente;
- c) al feticcio della conservazione e del prodotto: il testo è di per sé un feticcio – nella sua totalità, voglio dire –, un mito, in quanto raccoglie invisibili parametri, e il frammento non può essere la sua rappresentazione né la sua proiezione bensì una dissociazione da un linguaggio pacifico-ipnotico e poco insidioso.
I tre motivi citati hanno alcuni elementi in comune, elementi funzionali, le caratteristiche della riflessione e la rappresentazione dell’attimo, da non intendere come aura, ma come sosteneva Benjamin, «un singolare intreccio di spazio e di tempo» 1. Ma come può un [frammento] «che è linguaggio, essere fuori dei linguaggi?» 2, estraneo al feticismo, al mito? Si domandava Barthes ne Il piacere del testo. (Ho sostituito la parola testo con frammento, così anche più avanti, per dare più pregnanza alla risposta). «Come esternare (mettere all’esterno) [all’esterno del testo-feticcio i frammenti…] senza rifugiarci in un […] ultimo[o frammento]? […] Come può il testo “tirarsi fuori” dalla guerra delle finzioni, dei socioletti? […] [d]istrugge[ndo] fino in fondo, fino alla contraddizione, la propria categoria discorsiva […,] “la comicità che non fa ridere, l’ironia che non assoggetta, l’esultanza senz’anima, senza mistica […], la citazione senza virgolette?» 3. Il frammento avvicina le “cose”, in quanto la sua enigmaticità, il suo essere portatore di un discorso più ampio, la sua parziale “velatura”, sono attrazioni irresistibili e garantiste contro il perdurare delle codificazioni indesiderate. Pertanto, il frammento sancisce l’enigmaticità della poesia, il proliferare di operazioni materiche, il riordino della scansione poetico-critica, dove il gioco dell’ironia (e dell’autoironia), il divertissement, i giochi linguistici, la “neutralità” del fruitore diventano oggetti di una rivalorizzazione della pluralità. Come il silenzio rispetto alla voce o il segno rispetto al non-segno, così il frammento rispetto al testo “completo” è portatore di una invenzione continua, di una riproducibilità e irriducibilità straordinariamente aperte al tempo, a una gravidanza di forme intraverbali e immaginative plurime.
Dunque, quando parliamo di letteratura, di una certa letteratura, intendo – quella che ha sempre evitato il sacro, il secolare letargo simbolista –, difficilmente possiamo sottrarci alla peculiare importanza della “pratica del frammento”. Un’importanza camaleontica, magnetica, direi, che addita continuamente l’inutilità, ormai, della vecchia concezione aurorale dell’arte, del culto della Bellezza, delle Grazie, per farsi portatrice di un linguaggio materico e contraddittorio, mobile ed eterogeneo – specie se spericolato e irriverente, efficace contro il pericolo dell’assorbimento e della neutralizzazione di una ipotonia e ipofonia globalizzata da fasulli miraggi dove gli “attori” sono tutti di cartapesta o languidi fanciullini (pienamente corrispondenti al desiderio del “regista”), garanti di un gratuito e pacioso copione invertebrato. L’adozione del frammento in poesia equivale a ricercare qualcos’altro ed è paragonabile alla fragilità che domina la condizione umana, perché è attraverso la fragilità che l’uomo sente il bisogno dell’altro, l’altro da sé. Immaginate un potente: se ne frega dell’altro in quanto al di sopra di se stesso non riconosce che se stesso, così come la poesia in forma chiusa non riconosce altro al di fuori di sé. Ed è quindi contro la ricerca, la sperimentazione, la novità. In pratica: contro l’avanguardia.
A conclusione, un’altra domanda mi sovviene di formulare: ma c’è un futuro per la poesia in questo “villaggio globale” se si mette sul piano delle iniziative non più i metodi ma il metodo, non più le verità ma la verità, non più la relatività ma l’assolutezza, non più la provvisorietà ma la certezza effimera del linguaggio? Un compito davvero arduo attende la poesia in un sistema produttivo che genera stereotipi condizionati dall’equazione prodotto = denaro.
___________________
1 Walter Benjamin, L’opera d’arte nella sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 1966, p. 70.
2 Roland Barthes, Il piacere del testo, Einaudi, Torino, 1975, p. 30.
3 Ibidem.